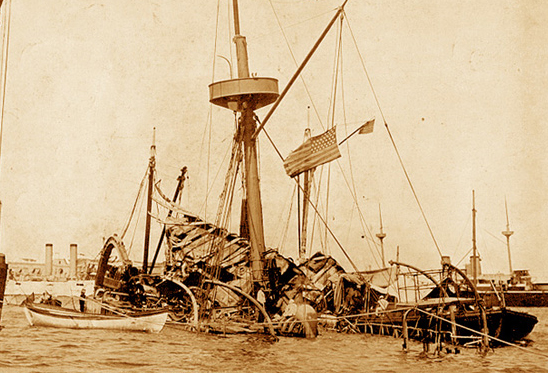
Ultimo
decennio del XIX secolo, dell’immenso impero
Spagnolo, sul quale, per usare le parole di
Carlo V, non calava mai il sole, non restano
che poche colonie: Cuba, Portorico, Guam, le
Filippine ed una piccola parte del Marocco.
D’altra parte, a differenza degli inglesi,
i monarchi spagnoli non hanno mai saputo trarre
grandi vantaggi da quell’impero. Forse
è mancata loro la necessaria capacità
organizzativa, certamente, sia stato per arroganza
o ottuso conservatorismo, non sono stati in
grado di comprendere e sfruttare i mutamenti
sociali e tecnologici degli ultimi due secoli.
Nel resto del mondo sono arrivati l’illuminismo
e la rivoluzione industriale. Nel 1776 è
stata scritta la dichiarazione d’indipendenza
americana. In Francia sono andati ben oltre
e dopo l’abolizione dei privilegi feudali
(4 Agosto 1789), ci sono stati la presa della
Bastiglia, la Rivoluzione, gli eccessi e gli
orrori del Direttorio e del Terrore. E’
stato persino ghigliottinato un re, e, dopo
di lui, sono stati giustiziati i suoi giudici:
Danton, Marat, l’incorruttibile Robespierre.
Napoleone ha sconvolto l’Europa, l’ha
illusa e l’ha tradita, sconfitto a Waterloo,
è stato rinchiuso nella gabbia dorata
dell’isola d’Elba. Risorto per cento
giorni e nuovamente sconfitto, ha certamente
avuto modo di riflettere sullo strano destino
delle cose umane contemplando silenziosamente
le onde dell’Atlantico infrangersi sulle
scogliere di un’inutile Sant’Elena.
Il congresso di Vienna (1816) ha dimostrato
l’impossibilità di riportare indietro
l’orologio della storia, migliaia di giovani
idealisti si sono sacrificati per il sogno romantico
delle identità nazionali. Byron è
morto in Grecia, diventerà immortale,
ma le sue opere saranno meno lette di quelle
del suo segretario Polidori, anche se nessuno
ancora lo sa, e Pellico ha scritto il diario
amaro delle sue Prigioni nel silenzio del carcere
duro dello Spitzerg.
Eppure, di tutto questo, nulla o quasi è
arrivato nelle ultime colonie spagnole, la macchina
burocratica antiquata, rigidamente assolutista
ha filtrato ogni aspirazione libertaria o umanitaria
mummificando la struttura sociale nella forma
di un arcaico, immutabile, conservatorismo.
Neppure la perdita, gravissima, delle colonie
sud americane, insorte e ribellatesi tra il
1810 ed il 1825 sotto la guida del libertador
Simon Bolivar, sembra aver insegnato nulla all’immobile,
superbo, impero spagnolo.
Nel frattempo, sulla scena internazionale, si
è affacciata una nuova potenza. Abbandonata
da tempo la politica di Monroe (L’america
agli americani), forti del dinamismo della loro
economia capitalistica e della superiorità
tecnologica delle loro industrie, gli Stati
Uniti si sono già espansi ai danni del
Messico ed hanno ora rivolto il loro interesse
a Cuba ed a Portorico nel tentativo di estendere
la loro area di influenza a tutto il Sud America
ed poi al Pacifico.
Ultimi decenni del XIX secolo, dunque. Cuba,
l’isola che Colombo aveva definito la
più bella tra tutte le terre, si dibatte
inutilmente sotto il giogo spagnolo. La nobiltà
iberica detiene la proprietà della
maggior parte delle risorse, in particolare
degli impianti saccariferi, mentre gli abitanti
dell’isola sono oppressi dalla burocrazia,
dai privilegi nobiliari, dall’eccesso
di tasse e tributi. Il caudillo Narciso Lopez,
nel tentativo di imitare i grandi libertadores
dell’america latina come Bolivar e San
Martin ha tentato per ben tre volte l’insurrezione
armata, la prima nel 1848. Ma viene arrestato
e giustiziato come un volgare bandito il 1°
Settembre del 1851.
Nel 1868, forse come conseguenza dell’esito
della Guerra di Secessione Americana (1861-1865),
forse per far fronte a tensioni sempre più
forti, i possidenti spagnoli decidono di abolire
la schiavitù, decisione comunque non
supportata ufficialmente dal governo d’oltreoceano.
Ma è troppo tardi, perchè dopo
pochi mesi scoppia la grande guerra, ovvero
la prima vera rivoluzione cubana. Ne è
promotore ed ispiratore Carlos Manuel de Cespedes.
De Cespedes è laureato a Barcellona,
discende da un’antica famiglia nobile
e, soprattutto, ha viaggiato per molti anni
in Europa, eppure è proprio lui l’uomo
che nel cortile dello zuccherificio di Demajagua,
davanti ad un piccolo gruppo di patrioti,
pronuncia per primo le parole “Libertà
o morte. Viva Cuba libera!”. E’
il 10 Ottobre 1868, quella notte gli insorti
conquistano il villaggio di Yara e, pochi
giorni dopo, la città di Bayano. La
grande guerra durerà dieci anni e costerà
più di 200’000 morti.
I ribelli, tra cui figurano nomi come Maximo
Gomez, Francisco Vincente Aquilera e Igacio
Agramonte, stringono contatti diplomatici
con gli Stati Uniti e sventolano la nuova
bandiera (due striscie bianche e tre azzurrre
che terminano in un triangolo rosso al cui
centro si trova una stella bianca) sulle città
conquistate. Però il governo spagnolo
non ha intenzione di rinunciare al controllo
sull’isola e la lotta si fa sempre più
cruenta. Il 25 Agosto 1871 “Placido”,
ovvero Juan Clemente Zenea, poeta libertario,
viene fucilato dalle autorità spagnole,
ignorando un salvacondotto ufficiale che esse
stesse avevano rilasciato. In Ottobre è
la volta di otto studenti di medicina, accusati
(forse ingiustamente) di aver violato la tomba
di un giornalista fedele alla corona. L’economia
dell’isola, basata sulla monocultura
dello zucchero - dal 1820 l’isola è
il maggior produttore di zucchero di canna
del mondo, grazie anche al lavoro di migliaia
di schiavi neri e gli Stati Uniti sono il
cliente principale del prodotto finito - è
a pezzi e già serpeggia lo spettro
della fame, mentre i rivoltosi tentano, sempre
inutilmente, la presa del porto dell’Avana.
Nel 1878 (12 Febbraio) le due parti esauste
siglano un precario cessate il fuoco, che
comprende vaghe promesse di maggiore autonomia
e l’abolizione, ufficiale, questa volta,
della schiavitù. La riconciliazione
effettiva è tuttavia impossibile, gli
spagnoli hanno perso 140’000 uomini,
sconosciuto ma certamente enorme il numero
delle perdite civili, ed incolmabile è
l’abisso scavato tra le due parti in
lotta da quel fiume di sangue. Inizia così
quella che gli storici chiamano piccola guerra,
una guerriglia scarsamente organizzata che
si trascina per due anni (1878-1880) fino
a quando il governatore spagnolo Camilo Polavieja
ripristina, con la forza delle armi, l’ordine
coloniale.
Gli Stati Uniti studiano segretamente l’annessione
dell’isola, gli Spagnoli cercano di placare
la comunità creola, i profughi cubani
emigrati in america pianificano il rovesciamento
del regime spagnolo a qualunque costo, tuttavia
ci vogliono altri quindici anni prima che
la rivolta popolare riesca a riorganizzarsi.
Alla guida degli insorti, questa volta, si
pone il tribuno Josè Marti, poeta e
saggista, che fonda il Partito Rivoluzionario
Cubano in esilio e firma assieme a Maximo
Gomez, eroe dell’insurrezione del 1868,
il Manifesto de Montecristi, chiamata alle
armi per tutta la popolazione cubana. E’
la rivoluzione popolare, che si estende in
breve a tutte le case, a tutti i villaggi,
forte anche dei finanziamenti che arrivano
dai cubani emigrati negli stati uniti. Martì
diventerà un eroe nazionale e morirà
in battaglia nel 1895, poche settimane dopo
essere sbarcato sull’isola.
Tuttavia in Spagna non ci si rende conto della
portata di questo movimento che viene considerato
come la “solita” rivolta coloniale.
I possidenti spagnoli non sono disposti a
concedere un’autonomia che avrebbe come
risultato la perdita del monopolio nella produzione
e nell’esportazione dello zucchero di
canna ed un nuovo esercito, quasi arruolato
a viva forza, viene spedito dal parlamento
sull’isola per riportare l’ordine.
E’ a questo punto che gli stati uniti
fanno la prima mossa ufficiale, schierandosi
formalmente dalla parte degli insorti, in
nome (sic) dei diritti umanitari. Però,
nel 1896, il governatore Martinez Campos viene
sostituito dall’implacabile generale
Valeriano Weyler che, contando su una forza
di oltre 200’000 uomini inizia una dura
repressione. La ribellione ha i suoi covi
in ogni villaggio, in ogni agglomerato urbano,
in ogni casa, allora Weyler decide di costruire
enormi campi di concentramento dove rinchiudere
tutti i sospetti di attività antispagnole.
In breve tempo i campi arrivano ad ospitare
(si fa per dire) più di 300’000
civili. Da un lato i ribelli avanzano bruciando
le piantagioni, dall’altra parte, Weyler
deporta i contadini, in pochi mesi l’economia
dell’isola è in ginocchio e la
popolazione conosce la fame e la miseria.
Il patriota Antonio Maceo scrive in quello
stesso anno “...non mi aspetto alcun
aiuto dagli americani (...) meglio cadere
o precipitare da soli che contrarre un debito
con un vicino tanto potente”. Maceo morirà
il 7 Dicembre 1896, in combattimento, e con
lui morirà, forse suicida, anche il
suo assistente di campo, il figlio di Maximo
Gomez.
Finalmente, nel 1897, le sorti del conflitto
si invertono, i ribelli controllano ormai
la zona centro est dell’isola e si moltiplicano
le diserzioni tra le fila degli spagnoli il
cui esercito, all’inizio del 1898 è
quasi dimezzato. Anche dall’altra parte
dell’Oceano il governo spagnolo inizia
a rendersi conto che la situazione non può
essere risolta con la forza. Quando il primo
ministro Antonio Canovas, nettamente contrario
a concedere qualsiasi forma di indipendenza
all’isola, viene assassinato da un anarchico
filocubano, il nuovo governo decide di tentare
un approccio più morbido.
La possibile riappacificazione fra Cuba e
la Spagna preoccupa gli Stati Uniti che decidono
di forzare gli eventi. Il 25 Gennaio del 1898
nel porto dell’Avana entra l’incrociatore
americano Maine. Ufficialmente, si tratta
di una visita di cortesia, in realtà
la sua missione è quella di controllare
la situazione più da vicino. Da un
lato si tratta di ricordare agli spagnoli
che Cuba si trova ai limiti della zona d’influenza
nord americana, dall’altra di riprendere
i contatti con il movimento rivoluzionario
che, in caso di vittoria, potrebbe rivelarsi
più difficile da controllare di quanto
previsto. Nel frattempo, gli ufficiali del
Maine passano pigramente le loro giornate
nei circoli militari spagnoli, bevendo ed
attendendo che succeda qualcosa.
E qualcosa succede. Sono le 21:43 del 15
Febbraio 1898, l’esplosione è
assordante e viene sentita in tutta l’Avana.
La gente si precipita in strada, i marinai
escono da osterie e bordelli. Non c’è
neppure il tempo di organizzare i soccorsi,
le fiamme si levano alte sul ponte squarciato
del Maine illuminando di riflessi rossastri
le acque calme del porto.
In pochi minuti l’incrociatore affonda,
parte dei marinai superstiti vengono soccorsi
dalla nave da guerra spagnola Alfonso XII,
altri riescono a raggiungere a nuoto le banchine
del porto. In totale mancheranno all’appello
2 ufficiali e 264 marinai. Un bilancio grave
(anche ammesso che qualcuno non sia morto
e ne abbia approfittato per disertare), anzi
gravissimo.
Un affronto che il governo statunitense non
può ignorare ma... chi incolpare?
I giornali americani dell’epoca non hanno
dubbi, specialmente quelli che appartengono
al miliardario Hearst, i cui interessi nei
confronti di Cuba sono noti a tutti e non
esattamente di tipo umanitario: si è
trattato di una mina piazzata nella stiva
dagli spagnoli. Un sanguinoso avvertimento
agli americani affinchè si tengano
lontani da Cuba.
In realtà, le cause dell’esplosione
restano estremamente incerte. Quale interesse
avrebbero avuto gli spagnoli a provocare in
quel modo il colosso statunitense? Certamente
i patrioti cubani ne avrebbero avuto un vantaggio
maggiore se, con quell’atto terroristico,
fossero riusciti a trascinare gli americani
nel conflitto. Nel 1911 il relitto è
stato tirato a galla e gli esperti hanno confermato
l’ipotesi di una mina, però un
secondo esame, condotto nel 1974 dall’ammiraglio
Hyman G.Rickover, sembra essere giunto ad
un diverso risultato. Nel rapporto finale
si legge semplicemente: “Le prove disponibili
sono coerenti con l’ipotesi di una esplosione
interna, generata probabilmente da un incendio
generatosi in un magazzino di carbone”.
Quale che sia la verità, l’opinione
pubblica indignata reclama vendetta ed il
colonnello Theodore Roosvelt organizza un
gruppo di volontari pronti ad attaccare gli
spagnoli con o senza l’appoggio del governo.
Il presidente Mc Kinley, ufficialmente, si
mantiene neutrale salvo poi cedere alla pressione
del parlamento ed appoggiare il partito interventista
di Hearst dopo che il governo spagnolo rifiuta
una offerta di trecento milioni di dollari
per l’acquisto dell’isola. Il 25
Aprile 1898 gli stati uniti dichiarano guerra
alla Spagna, la flotta americana, però,
è già schierata attorno all’isola
dal 21 Aprile.
I patrioti cubani non sono del tutto convinti
della situazione ma, tra i due mali, scelgono
il minore e Calixto Garcia, capo delle forze
che controllano la zone est dell’isola,
si accorda con il generale Shafter per portare
un attacco congiunto. Gli americani sbarcano
il 24 Giugno 1898 sulla spiaggia di Daiquiri,
è un piccolo contingente: 15’000
soldati, 800 ufficiali, 16 cannoni leggeri,
ma le loro armi sono più moderne ed
affidabili di quelle dei loro avversari. In
breve tempo il controllo spagnolo sull’isola
è limitato alla sola capitale.
Tre Luglio 1898, grande fervore nella città
assediata di Santiago, l’Ammiraglio Cervera
ha ricevuto l’ordine di imbarcare i suoi
marinari e dare battaglia in mare aperto.
E’ un suicidio, come vedremo, ma Cervera
non ha altra scelta che obbedire. L’ammiraglio
Sampson, le cui navi bloccano l’uscita
del porto, si accorge immediatamente delle
manovre spagnole e da ordine ai suoi di prepararsi
alla battaglia. Tanto la nave ammiraglia spagnola,
la Maria Teresa, quanto le altre navi, gli
incrociatori Oquendo, Vizcaya e Colon o i
cacciatorpedinieri Pluton e Terror sono vecchie
navi da guerra, lente e poveramente protette.
Hanno corazzamenti inferiori e bocche da fuoco
a gittata ridotta rispetto a quelle statunitensi.
Troppo ridotta.
E’ una sorta di orribile tiro al bersaglio,
le moderne corazzate Indiana, Oregon, Iowa
e Texas guidate dall’imponente ammiraglia
Brooklyn aprono il fuoco sugli avversari quando
questi sono ancora troppo lontani per rispondere.
Le navi spagnole vengono letteralmente fate
a pezzi dalle esplosioni che si succedono
una dopo l’altra. Dense colonne di fumo
interrompono le comunicazioni e la confusione
generale rende impossibile la fuga. Non ci
vuole molto perchè i comandanti spagnoli
si rendano conto di non avere nessuna alternativa,
molte navi allora invertono la rotta e puntano
verso i bassi fondali dell’isola: tentano
di insabbiare gli scafi per salvare i marinai
dall’affondamento.
In meno di un’ora la baia è diventata
un immenso cimitero cosparso di carcasse di
navi spagnole.
Gli iberici contano 350 morti, 500 feriti
e 2000 prigionieri. Gli americani un morto
e due feriti.
Santiago si arrenderà una settimana
dopo, l’11 Luglio 1898, costretta dal
bombardamento navale americano.
Gli americani sbarcano in città il
17 Luglio accolti come liberatori ma il primo
atto ufficiale è quello di negare ai
capi della rivolta il diritto di entrare a
Santiago alla testa delle loro truppe.
Ostinatamente, il governo degli stati uniti
rifiuta di riconoscere il partito rivoluzionario
cubano e, tantomeno, la Repubblica da essi
rappresentata. E’ una misura temporanea,
dicono, in realtà il riconoscimento
ufficiale non arriverà mai. Formalmente
gli statunitensi non possono annettere Cuba
come hanno fatto con Portorico, Guam e le
Filippine perchè nella dichiarazione
di guerra è presente l’impegno
a rispettare il diritto di autodeterminazione
del popolo cubano. Di fatto, inizia una occupazione
militare.
L’Emendamento Platt del 1903 attribuisce
al governo USA il diritto di intervenire militarmente
negli affari interni dell’isola. E’
l’unica alternativa all’occupazione
militare ed i cubani sono costretti ad accettare
l’elezione di un governo fantoccio. Nello
stesso anno viene costruita sull’isola
la base militare americana di Guantanamo,
oggi tornata, tristemente, agli onori delle
cronache.
Della battaglia nella baia di Santiago restano
poche tracce, una stele di marmo in Columbus
Square, nell’estremità sud occidentale
del Central Park di New York ricorda i morti
del Maine (una curiosità, la statua
della Columbia trionfante che sormonta la
stele è opera dello scultore Attilio
Piccirilli (1866-1945), Carrarese di nascita,
newyorkese d’adozione ed amico personale
di un altro italo americano d’eccezione,
Fiorello La Guardia), un’altra stele,
non molto dissimile, si trova sul lungomare
dell’Avana. I marinai spagnoli, che io
sappia, non sono celebrati da nessuna parte.
D’altra parte nessuno ricorda mai gli
sconfitti.
Tre mesi di guerra ed una battaglia navale
durata poco meno di un’ora, sono bastati
a cancellare dalla mappa mondiale il secolare
impero coloniale spagnolo e, con esso, l’era
del colonialismo. Il nuovo potere capitalistico
impone strumenti di controllo più sottili
ed efficaci, è l’alba dell’imperialismo.
Il resto è storia recente. Già
negli anni ‘20 società statunitensi
possedevano i due terzi delle terre cubane,
il governo dell’isola sfavoriva palesemente
lo sviluppo di aziende locali sostenendo,
invece, il turismo legato alla prostituzione
ed al gioco d’azzardo. Le rivolte popolari
successive alla crisi del ‘29 furono
soffocate nel sangue dal presidente Gerardo
Machado y Morales. Machado viene a sua volta
deposto dal colpo di stato del sergente Fulgencio
Batista nel 1933. Uomo di paglia nelle mani
degli americani, Batista manterrà lo
status quo sull’isola con alterne fortune
per i trent’anni successivi, salvo fuggire
nella Repubblica Dominicana (portando con
sé quaranta milioni di dollari di denaro
pubblico) nel 1958, spaventato dalla campagna
di guerriglia condotta dal giovane avvocato
Fidel Castro e dal medico argentino Ernesto
“Che” Guevara. Fidel Castro verrà
nominato ufficialmente primo ministro il 1°Gennaio
1959, quasi contempraneamente gli Stati Uniti
terrorizzati (o indignati?) da quel vicino
di casa dichiaratamente comunista (anche se
fino al 1961 non ci sarà una formale
adesione al socialismo) dichiareranno un durissimo
embargo ed interromperanno le relazioni diplomatiche
con l’isola. Siamo a meno di due anni
dallo sbarco alla Baia dei Porci.
A cura di Marco R. Capelli
marco_roberto_capelli@progettobabele.it